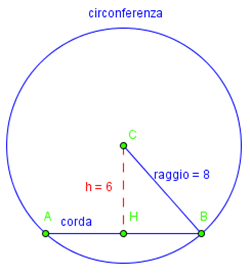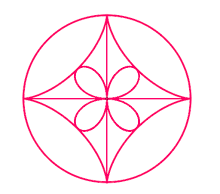Con Geogebra
Home page * GeoGebra * Excel * Matematica nella Storia. I Grandi Matematici * Matematica ricreativa * Libri * Le Curve Celebri * Immagini per la Matematica * Tutoriali * Le Formule più belle * Matematica e ... *
Altri modi per visualizzare il blog
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SUI COOKIE
*MATERIALE DIDATTICO *Risorse didattiche e SCUOLA *BLOG DIDATTICI e colleghicheleggo *Risorse EXCEL - OFFICE *Info CREARE e ARRICCHIRE IL PROPRIO BLOG *Altro Blogroll *Condivisioni *Visualizzazione formule matematiche
lunedì 11 aprile 2011
giovedì 11 febbraio 2010
Un problema numerico. Da …
Direttamente da
PI GRECO QUADRO del prof Daniele Gouthier,
ragazzi (e lettori!), provate a scoprire la relazione x & y.
Per i ragazzi della prima: non fatte caso a “x e y” (anche se lo sapete già che con le lettere possiamo generalizzare ). Provate invece a ragionare sugli esempi: quale regolarità porta a ottenere quei risultati?
Clic!
Problema numerico | Pi greco quadro via kwout
Ringraziamo prof Daniele.
mercoledì 30 dicembre 2009
Per esercitarsi…
Ragazzi di I,
Se avete voglia di esercitarvi, on line oppure scaricando delle schede di lavoro, nell’esecuzione di espressioni con i numeri naturali e nella risoluzione di problemi(ni),
una segnalazione per voi.
Come vedete in figura, trovate delle pagine guida di teoria, dei test propedeutici, esercizi guidati, esercizi per mettersi alla prova ed anche di …preparazione alla verifica scritta! (Questi sono solo su espressioni e problemi, voi naturalmente ricordate che dovete conoscere la struttura e proprietà in N delle quattro operazioni)
Clic sulla figura
domenica 31 maggio 2009
Problemi con frazioni: prodotto di numeri uno frazione dell'altro
Ragazzi,
abbiamo spesso incontrato nella risoluzione dei problemi geometrici la somma o differenza di numeri uno frazione dell'altro. ("numeri" che in geometria sono *misure di grandezze*. Fate clic e andate a rivedere se è il caso)
Meno frequentemente e con qualche evidente difficoltà, abbiamo incontrato la situazione:
conosco il prodotto di due numeri, uno frazione dell'altro. Quali sono i due numeri?
In geometria il problema si è presentato nella forma:
L'area di un rettangolo è di ... cm². Le due dimensioni sono l'una i ... (frazione) dell'altra. Quanto misurano le due dimensioni?
(Naturalmente questo è il problema nel suo "cuore". Lo abbiamo visto: potete avere il rettangolo equivalente ad altra figura, conoscere o dover calcolare l'area di quest'ultima, e la richiesta può essere il perimetro del rettangolo. Il *problema* consiste comunque nel trovare la misura delle due dimensioni).
Ho deciso dunque, affinché possiate ricontrollare ... che so, durante le vacanze, quando dedicherete qualche ora alle esercitazioni nella risoluzione di problemi, di riportare qui il facile ragionamento da seguire.
Consideriamo un esempio concreto:
Un rettangolo ha l'area di 810 cm². Una dimensione è pari ai 2/5 dell'altra. Qual è la loro misura?
L'area del rettangolo, sappiamo, è il prodotto delle due dimensioni, b e h. Ecco perché il problema rientra nel "tipo": prodotto di numeri, uno frazione dell'altro...
In questo caso, poiché conosco l'area (della superficie) del rettangolo, devo lavorare in primo luogo sull'interno della figura, servendomi dell'indicazione: dimensione una i 2/5 dell'altra.
Ipotizzo la base i 2/5 dell'altezza, b = 2/5 h (o, volendo: h=2/5 di b)
Lavoro sull'interno della figura con questa costruzione:

Sì, in 10 parti uguali (giusto il prodotto 2*5!)
Ma se queste parti sono dei quadrati, che si può fare?
Ehi, lavoriamo sulle "aree", dunque?
Mah! Se conoscessi la misura dell'area di ciascun quadrat(ino)... potrei calcolare il suo lato.
E avrei la misura di ogni.... quinto!
Su dunque, con il nostro esempio!
Aquadr = Arettang /10 = 810/10 = 81 cm²
l quadr = √Aquadr = √81 = 9 cm
9 cm è dunque la misura di 1/5 dell'altezza
Per cui, la base è pari a 2/5:
b = 9 * 2 = 18 cm
l'altezza è pari a 5/5:
h = 9 * 5 = 45 cm
Problema risolto!
Volendo riunire in unica formula il calcolo della misura delle due dimensioni:

...buone esercitazioni eh!
venerdì 9 gennaio 2009
La divisione: consapevolezze!
Letto ieri su Giornale di classe,
ho proposto stamane ai ragazzi di seconda il problema:
Un professore di matematica, per decidere quale allievo interrogare procede nel seguente modo: moltiplica per 2 i giorni del mese e divide il risultato per il giorno della data odierna. Il resto della divisione individua il numero nell’elenco dell’alunno da interrogare. Se il resto è zero non viene interrogato nessuno.
Oggi è uscito il numero 16. Sappiamo che il mese è novembre e che il quoziente della divisione è 2.
Che giorno è oggi?
Abbiamo osservato che non può essere mai interrogato uno studente il cui numero sul registro è uguale o superiore al giorno della data odierna.
Perché?
hanno risolto così:
60 -16 = 44
44 : 2 = 22
x = 22
spiegandomi:
tolgo 16 da 60 perché così ho un numero che diviso per quella data non mi da resto.
Il numero è 44, lo divido per 2 per fare l'inversa, e mi da 22. La data era il 22.
La seconda risposta ha richiesto qualche sollecitazione in più, comunque è stata data:
perché il resto della divisione non può mai essere uguale al divisore oppure maggiore, altrimenti sbaglio la divisione!
Bravi raga!:-)
giovedì 8 gennaio 2009
La fontana. E le progressioni aritmetiche
Ragazzi, un semplice problema:
La fontana.
La prima vasca, dove c’è lo zampillo, contiene 5 litri d’acqua.
La seconda contiene 8 litri in più della prima, la terza 8 litri in più
della seconda e così via sino alla settima.
Quanti litri contiene complessivamente la fontana quando le 7 vasche sono tutte colme?
L'ho premesso, il problema è semplice, direi elementare, e sono certa che non avrete difficoltà a risolvere.
Tuttavia esso ci dà l'occasione per approfondire, in qualche caso affrontare, il discorso sulle progressioni aritmetiche.
Consiglio di rivedere qui sul blog Inserimento dati in Excel e soprattutto
Numeri poligonali. Su quest'ultimo, andate in particolare al punto: I numeri poligonali si possono ottenere sommando gli elementi di progressioni aritmetiche...
Vi accorgete che in una progressione aritmetica la differenza fra qualsiasi termine ed il suo precedente è costante.
Es:
1+2+3+4+.... (ragione r=1, numeri triangolari): 2-1=1; 3-2=1; 4-3=1; ecc.
1+3+5+7+... (ragione r=2, numeri quadrati): 3-1=2; 5-3=2; 7-5=2; ecc.
1+4+7+10+13+... (ragione r=3, numeri pentagonali): 4-1=3; 7-4=3; 10-7=3; ecc.
E' la differenza costante tra due termini consecutivi che viene appunto chiamata ragione (r) della progressione.
Ora, notate che nel nostro problema della fontana abbiamo a che fare con una progressione aritmetica?
Il problema chiede i litri di acqua totali quando le 7 vasche siano piene.
Possiamo dunque vederlo come:
Somma di n termini consecutivi di una progressione aritmetica.
Sotto forma di gioco matematico, sul blog abbiamo già incontrato un problema simile: ... alla corte di Carlomagno. Problemi per rendere acuta la mente dei giovani
Su quel post non lo scrissi, ma:
Si racconta che il maestro delle elementari di quello che sarà chiamato il re dei matematici, C.F. Gauss, propose questo problema sperando di impegnare i suoi studenti per almeno 1 ora: “Sommare i primi 100 numeri naturali”. Quello che chiedeva il maestro era determinare il risultato di: $\sum_{n=1 }^{100 } n = S_{100} = 1+ 2 + 3 + 4 + ... + 100$
[questo bel simbolo è quello di sommatoria, si usa per indicare, in forma compatta, una somma da... a..., è la lettera sigma maiuscola dell'alfabeto greco]
Gauss risolse il problema in molto meno di 1 ora, senza alcun errore! Ecco come fece.
Dispose i numeri da 1 a 100 in ordine crescente e poi li riscrisse allineati in colonna ordinandoli in modo decrescente.
Infine eseguì la somma in colonna scoprendo che otteneva 101 ogni volta, ossia 100
volte .
100, 99, 98, ...., 3, 2, 1
_________________________________
101, 101, 101, ... , 101, 101, 101
(per 100 volte)
Si ottiene la formula generale:
Il primo termine della progressione è ... ? L'ultimo termine è ... ? (quanti 8 bisogna aggiungere?)
Ma non finisce qui! :-)
Volutamente più sopra, ho scritto la progressione aritmetica del contenuto delle vasche in quel modo così ordinato (anzi, ho creato appositamente un'immagine).
Eh, volevo dare l'idea di un ... trapezio!
Ma forse è meglio se lo rappresento così:
La formula per il calcolo della somma dei termini di una progressione qualsiasi non ricorda quella dell'area di un trapezio?
Somma delle basi : (a1 + an)
per altezza: (n)
diviso 2.
Ancora una volta abbiamo quindi dato un significato geometrico ai numeri, in questo caso a una formula.
martedì 2 dicembre 2008
Problemi con frazioni: somma o differenza tra numeri uno frazione dell'altro
Copio-incollo dal file di Gian Mario (gimmi forte!)...
Oggi (riferito a giovedì 27-11), dopo aver finito il compito in classe la prof, per non farci riposare troppo (ops, schiavista d'una prof!:-)), ha dato a me e Anna Laura delle "piccole aggiunte" che consistevano in problemi nuovi, che dovevano essere svolti inventandoci noi il metodo, perché non li avevamo ancora studiati.
Mi son chiesto: ce la farò? Posso rifiutarmi? Povero me! Ma ci voglio provare!!!!!
Il primo problema riguardava le
somme di numeri, uno è frazione dell'altro: trovare i due numeri
Trovare due numeri la cui somma è 63 e uno è i 4/5 dell'altro. Io e Anna Laura ce la siamo cavata facendo un procedimento ben preciso.
Guardate:
la somma di due numeri è 63. Un addendo equivale a 4/5 dell'altro, quindi l’altro è 5/5. Siccome avevo la somma, ho sommato anche le frazioni che corrispondevano ai numeri.
Siccome avevo la somma, ho sommato anche le frazioni che corrispondevano ai numeri.
Quindi 9/5 = 63. E ho calcolato il valore di 1/5 che è uguale a 7.
Per trovare il valore dei due addendi, moltiplico il 7 cioè 1/5 per i due numeratori 4 e 5.
Questo perché un numero è 4/5, l'altro 5/5:
7 x 4 = 28 = 4/5
7 x 5 = 35 = 5/5
Dopo aver ottenuto i due numeri li sommo per verificare che il risultato è proprio 63:
35+28=63
Il 2° problema riguardava
la differenza: trovare due numeri conoscendo la loro differenza e uno frazione dell'altro.
Trovare due numeri la cui differenza è 25 e uno è 7/2 dell'altro.
La differenza dei due numeri è 25.
Il minuendo è uguale a 7/2 e il sottraendo a 2/2.  Anche qui, siccome avevo la loro differenza ho sottratto anche le frazioni.
Anche qui, siccome avevo la loro differenza ho sottratto anche le frazioni.
Quindi 25 = 5/2 e ho calcolato il valore di 1/2:
25 : 5 = 5 = ½
Per ricavare il valore del minuendo:
5 x 7 = 35 = 7/2
e del sottraendo:
5 x 2 = 10 = 2/2
Per verificare, eseguo la sottrazione fra i due numeri: la differenza è 25.
35 – 10 = 25
Gimmi (e Anna Laura), bravo/i!
Eh eh...ma come, "rifiutarti"? Vedi com'è facile "farcela"! :-))
martedì 27 maggio 2008
Due problemi sulle aree di triangoli
Alessandra e Irene, per altro poco in forma in questo periodo... :-)
decidono di accontentare qualche richiesta dei nostri lettori e propongono la risoluzione di due problemi sull'area del triangolo.
Il problema di Alessandra:
Testo:
In un triangolo isoscele gli angoli alla base misurano 45° ciascuno. Il lato BC misura 32 cm. Quanto misura l’area?

Poi, siccome la misura degli angoli interni di un triangolo è di 180°, allora se gli angoli alla base sono di 45° ciascuno, l’angolo al vertice misura 90°, angolo retto: si tratta di un triangolo rettangolo isoscele.
Posso dire di aver risolto il problema, in quanto conosco i dati necessari per trovare l’area di un triangolo, ossia la base e l’altezza.
Infatti, essendo i due cateti perpendicolari tra loro, costituiscono la base e l'altezza del triangolo.
Ruotando il triangolo, mi accorgo che effettivamente conosco la base e l’altezza del triangolo [privilegio la posizione orizzontale-verticale].
sabato 3 maggio 2008
[Esercitazioni] Risoluzione di problemi
Irene e Nicola mi inviano la loro risoluzione di due problemi di geometria.
Irene dice:
Risolvo un problema usando un metodo che praticamente segue il procedimento Top-down, senza schema ma partendo dalla richiesta finale, con le domande in successione...
Un lato supera l’altro di 21 cm.
Calcola la lunghezza dei lati del parallelogramma.
raccolgo i dati e le richieste
DATI
P = 258 cm*
AB = BC +21 cm
RICHIESTE
AB = ?
BC = ?
Parto dalle richieste finali.
Comincio a preparare il lavoro, prima per il lato AB.
I dati mi dicono che AB supera di 21 cm BC, quindi:
AB = BC + 21 cm = ...
BC, lo conosco? NO, me lo vado a preparare:
la figura mi suggerisce che BC è una delle 4 parti uguali che restano se dal perimetro sottraggo le "quantità" in più che AB ha rispetto a BC, quindi:
BC = (P - 21 x 2)/4 = ...
Perimetro lo conosco? SI
Posso dire di aver quasi concluso! Perché, appena mi rispondo SI, non mi resta che mettere al posto delle lettere i numeri. E risalgo ... "gradino per gradino".
Ecco l'immagine

Etichette: Risoluzione di problemi
giovedì 1 maggio 2008
Bottom-up e Top-down
Ragazzi, carino questo titolo vero? Io che non so l'inglese, mi sono concessa questa ... diciamo bizzarria! Direte voi: e di che si tratta?
Si tratta di due strategie per risolvere problemi!
Con la vostra parola (mmmh, che illusa!): aver letto (o leggere prima) il post precedente (fate clic!) sulla risoluzione di un problema geometrico,
vi spiego qui questi metodi alternativi. Una volta compresi, potrete scegliere quello a voi più congeniale. Oppure, sarete sempre liberi di utilizzare il "vostro" metodo! Anzi!
Cominciamo con la prima strategia: Bottom-up
Bottom-up è un termine inglese che significa: "dal basso verso l'alto".
Nella risoluzione di un problema il metodo consiste nello studiare attentamente i dati a disposizione, per capire se da questi si possano ricavare le informazioni utili per giungere alla soluzione:
dai dati ai risultati.
Come esempio riprendiamo lo stesso problema del post precedente:
In un trapezio isoscele il lato obliquo è lungo 10 cm, il perimetro 50 cm, e la base maggiore è tripla della minore.
Determina la lunghezza delle due basi.
Si realizza un grafico come quello in figura:

Osservate il grafico con attenzione (cliccate sull'immagine per ingrandirla): esso evidenzia il procedimento da usare per la soluzione del problema.
Notare: bisogna specificare inizialmente tutti i dati, anche quelli "impliciti". Per es il dato: n° lati obliqui, è un dato implicito, che nasce dalla conoscenza delle proprietà del poligono in questione.
Per quanto riguarda le due basi, non si ha il dato numerico ma, vi accorgete, è utile specificare l'informazione: B=3xb.
Infine, anche i colori delle caselle sono significativi. Un colore per i dati iniziali, uno per i risultati intermedi e un altro colore per i risultati finali.
Vediamo ora il secondo metodo: Top-down
Top-down significa: "dall'alto verso il basso".
Nella risoluzione di un problema il metodo consiste nel partire dalla fine: ragionando sul risultato richiesto, si ricavano via via le informazioni che servono per ottenerlo:
dai risultati ai dati
Per applicare il metodo bisogna porsi delle domande, in successione:
- quali valori servono per calcolare il risultato finale?
- ho già pronti, conosco questi valori?
- se non li conosco, quali valori servono per calcolarli?
- e così via per fasi successive.
Osservate il grafico (il problema da risolvere è ancora quello sul trapezio):
studiamolo insieme passo a passo:
i risultati richiesti sono: la lunghezza della base maggiore e della base minore del trapezio.
(l'attenta lettura del testo del problema resta indispensabile)
Mi pongo le domande:
1) come posso calcolare la base maggiore?
so che è il triplo della minore, dunque:
- b (base minore) x 3 (controlla sul grafico, così di seguito per ogni domanda e risposta)
2) conosco la base minore? - NO
3) come posso calcolare la base minore?
- dividento per 4 la somma delle due basi, in quanto tale somma è costituita da 4 parti congruenti alla base minore (osserva la parte destra del grafico per capire come ottenere il valore 4: somma parti uguali delle basi).
4) conosco la somma delle due basi? - NO
5) come posso calcolare la somma delle basi?
- sottraendo dal perimetro la somma dei lati obliqui
6) conosco la misura del perimetro? - SI
7) conosco la somma dei lati obliqui? - NO
8) come posso calcolare la somma dei lati obliqui?
- moltiplicando per 2 la misura di ciascun lato obliquo in quanto essi sono congruenti
9) conosco la misura di ciascun lato obliquo? - SI
Posso ritenere di aver concluso: ho impostato tutti i passi necessari per la risoluzione del problema.
Non resta che "risalire" (una salita meno faticosa della discesa!) eseguendo i calcoli indicati e scrivendo i risultati nelle caselle vuote a fianco alle rispettive indicazioni, via via fino al risultato finale.
mercoledì 30 aprile 2008
Problemi!
Il titolo del post è molto significativo!:-)
Si riferisce (ancora una volta) alla risoluzione dei problemi, quelli geometrici, e al fatto che …sono problemi!!!
Ma si, ragazzi, non scoraggiamoci. Lo so, vi vengono difficili, se vi consola, non siete soli… sapete quanto si ripete la "chiave di ricerca" che porta al nostro blog: "come risolvere problemi di geometria" ?
Suu… si può imparare!
Sappiate che saper risolvere un problema fa…crescere! (perciò sono difficili, crescere è faticoso!)
Poi, "risolvere un problema": lo dice la parola stessa. Noi ci serviamo di quelli di geometria, ma impariamo a sapercela cavare nella risoluzione dei problemi che ci si presentano nella vita.
Sì, perché servono per sviluppare molte abilità: saper utilizzare informazioni, saper “mettere insieme” opportunamente le proprietà che si conoscono, saper utilizzare in modo appropriato le operazioni, sviluppare le capacità logiche, saper fare delle scelte, riconoscere dati importanti e/o superflui, riconoscere informazioni "implicite" ecc.. …
E se si è forti in queste capacità, ci si sa "difendere".
Bando alle ciance ora!
Con la speranza di dare un aiuto a voi e ad altri… facciamo un esempio di
Il testo del problema
In un trapezio isoscele il lato obliquo è lungo 10 cm, il perimetro 50 cm, e la base maggiore è tripla della minore.
Determina la lunghezza delle due basi.
Come cominciare?
Leggo il problema una prima volta. So che è un problema di geometria, e nella risoluzione di questo tipo di problemi, la figura, non aiuta, ma… suggerisce! (presente quando voi suggerite la risposta a un vostro compagno? Gliela date bell'e pronta!)
Per prima cosa dunque disegno la figura di cui tratta il problema.
Dovrei, possibilmente, disegnare la figura in scala, rispettando il rapporto fra le misure delle grandezze fornitemi, per ora possiamo accontentarci di
disegnarla verosimile: devo cioè "guardare in faccia" le misure delle grandezze (sì, perché spesso i numeri si leggono ma non si "pesano", non si fa la stima della "quantità", è vero??) e disegnarla rispettando quanto più possibile il confronto tra le misure delle grandezze date.
Nel nostro problema, si parla di un trapezio isoscele.
Attenzione! Già una preziosissima informazione: non è un trapezio qualsiasi.
Si presentano già "le conoscenze che ho": le proprietà del trapezio isoscele. So che ha i due lati obliqui congruenti.
Per disegnare la figura verosimile, rileggo ancora il testo.
Trovo: "la base maggiore è tripla della minore"
Rifletto: trapezio isoscele, base maggiore tripla della minore….
Se ho il quaderno a quadretti dovrei disegnare abbastanza correttamente:
traccio il segmento che costituirà la base minore (5 quadratini?)
il trapezio è isoscele, quindi le proiezioni dei lati obliqui sulla base maggiore sono uguali. Ne tengo conto.
Traccio sotto, a una certa distanza dalla base minore, un segmento ad essa parallelo e conguente. Così:
Comincio a costruire la base maggiore che è tripla della minore: prolungo dunque il secondo segmento, da ciascuno dei suoi estremi, con altri due di lunghezza congruente ad esso, così:
Chiudo la figura (qui completo con qualche indicazione) e indico i vertici con le lettere maiuscole.
Come vedete, in figura, ho anticipato un altro suggerimento: spesso aiuta scrivere sulla figura stessa i dati conosciuti. Ho scritto sui lati obliqui la misura della loro lunghezza.
Passiamo alla seconda, importante fase:
devo tradurre i dati del problema dall'italiano al "matematico", con il codice della matematica.
Ancora rileggo il problema (sì, non vi appaia esagerato, la lettura e rilettura fanno comprendere!),
concentrandomi sui dati che mi sono forniti.
"il lato obliquo è lungo 10 cm"
Traduco osservando la figura: AD = BC = 10 cm
"il perimetro 50 cm"
Traduco: P = 50 cm
"la base maggiore è tripla della minore"
Questa traduzione è più difficile?
Cosa vuol dire triplo?
Sì, 3 volte tanto, preso 3 volte.
In matematica come traduco preso 3 volte?
x 3, vero?
Dunque:
"la base maggiore è tripla della minore"
Traduco: AB = DC x 3,
o anche, se indico con B maiuscola la base maggiore e b minuscola la minore: B = b x 3
Meglio se avrò raccolto i dati in uno schema:
AD = 10 cm
P = 50 cm
B = b x 3
Indico in "matematico" anche le richieste del problema:
"Determina la lunghezza delle due basi"
Traduco: AB = ? e DC = ?
E ora ... il bello!
Qualche volta si tende a impostare subito un calcolo senza troppo …riflettere!
Ma le operazioni aritmetiche hanno un loro significato. Un loro preciso utilizzo!
Un problema non ha un unico procedimento di risoluzione.
Qui ve ne illustro uno. E' facile!
Per aiutarvi nella giusta scelta delle operazioni da utilizzare, vi guido nel modo seguente.
Considerate la richiesta del problema: determina la lunghezza delle due basi del trapezio.
Ponetevi la domanda: le 2 basi costituiscono un totale oppure una parte di un tutto?
Una parte del totale, vero?
E se NON conosco e voglio trovare una parte di un totale, quali sono le operazioni da utilizzare?
Escludo l'addizione e la moltiplicazione, che come risultato danno un "totale".
Rifletto ora sui dati: conosco un "totale"?
Certo, è il perimetro, che è la somma delle misure dei lati (perì = attorno, contorno e metro(n) = misura, misurare)
Però ho l'imbarazzo: ci vorrà la sottrazione oppure la divisione?
Ma… in quali casi si usa la sottrazione, in quali la divisione?
La divisione, sicuramente divide in parti uguali!
Stavolta non ho un totale costituito da parti uguali.
Le parti da trovare sono una parte del perimetro che è costituito da parti disuguali. Non ho mica un quadrato!:-)
Quindi… bèh non mi resta che scegliere la sottrazione!
Ma, ho ancora dubbi: come trovo queste due basi?
Per cominciare ad impostare la soluzione, devo riflettere che:
un problema si risolve, oltre che con le conoscenze in mio possesso, con i dati che ho! (Sembra banale? Ma voi spesso mica ci pensate!)
Quindi: come usarli?
Osservo ancora una volta i dati.
Conosco il perimetro,
conosco la misura di ciascun lato obliquo, ne ho 2 congruenti.
So che la base maggiore è tripla della minore (questo ancora mi sa che non mi aiuta…)
Osservo attentamente la figura…
Devo usare una sottrazione….
Oh! Se dal perimetro sottraggo i due lati obliqui… posso anche provare a cancellarli per un attimo con una barra, se sono alla lavagna cancello proprio con cimosa!
Mi restano le due basi!
Posso decidere di passare all'impostazione della soluzione:
AB e DC = perimetro – i due lati obliqui
Ehmm… traduco:
AB+DC = P – ADx2 (sono uguali i due lati obliqui, no?)
Ora
Sostituisco alle lettere i numeri:
AB+ DC = 50 – 10x2 = 50 – 20 = 30 cm
La somma delle due basi è di 30 cm
E ora?
Come trovarle separatamente?
Ma, non abbiamo detto che la figura suggerisce?
Osserviamola ora puntando la nostra attenzione solo sulle due basi.
Conosco la loro somma.
E, non è una somma fatta di parti uguali?
Quante parti uguali?
Béh.. si che ho capito!
La somma diviso 4
E… devo sempre chiedermi: cosa trovo?
Osservo ancora la figura
Dividendo per 4 il totale delle due basi, trovo la misura di ogni parte.
Una di queste parti cosa costituisce?
La base minore!
Dunque:
DC (oppure b) = somma basi / 4
Uso il simbolo di frazione (sono alle medie!)
In simboli
DC = (AB+DC)/4
Al posto delle lettere i numeri:
DC = 30/4 = 7,5 cm
e, AB?
Ma è il triplo!
AB = DC x 3 = 7,5 x 3 = 22,5 cm
R i s o l t o!!!
Per sicurezza: 22,5 cm + 7,5 cm = 30 cm. OK!
E anche: 22,5+7,5+10+10= 50 cm OK, è il perimetro. E' tutto a posto!
domenica 21 ottobre 2007
I problemi moltiplicativi
Introducendo La risoluzione dei problemi aritmetici
si era detto che i problemi aritmetici che a noi interessa saper risolvere possiamo distinguerli in 2 tipi:
- additivo: si risolvono con l'uso dell'addizione o della sottrazione
- moltiplicativo: si risolvono con l'uso della moltiplicazione o della divisione.
La moltiplicazione vista in tre modi diversi.
Analogamente a quanto visto per l'addizione, consideriamo una moltiplicazione scrivendo i suoi termini con le lettere al posto dei numeri, in modo da indicare, come sappiamo, una moltiplicazione qualsiasi.
a * b = c
alle lettere a e b, i due fattori, possiamo sostituire due numeri qualsiasi e alla lettera c il loro prodotto.
Se dividiamo il prodotto per uno dei due fattori otteniamo il secondo fattore. Cioè possiamo scrivere:
c : a = b
c : b = a
La divisione è infatti l’operazione inversa della moltiplicazione. Quella che ci permette di…tornare indietro.
Le operazioni scritte possiamo anche considerarle tre modi diversi per scrivere la moltiplicazione.
I tre modi ci permettono di calcolare un termine conoscendo gli altri due.
Ogni volta che si pensa ad una moltiplicazione è importante pensarla sotto questi tre punti di vista.
Ancora una volta ricordiamo che è utile inquadrare la tipologia del problema.
Per quanto riguarda i problemi moltiplicativi possiamo riconoscere una ripetizione di misure o di oggetti, oppure una ripartizione di misure, di oggetti, in parti uguali.
Cominciamo dunque a considerare qualche semplice esempio di problema che prevede l'uso della moltiplicazione o della divisione.
- 7 amici posseggono ciascuno 5 euro. Quanti euro posseggono in totale (complessivamente)?
- Un quaderno costa 2 euro. Quanto spendo per acquistarne 5?
Sono certa che sapete risolvere facilmente problemi di questo tipo. Riconoscete in essi la ripetizione di misure, di quantità.
E sapete anche che la moltiplicazione è l'operazione che vi permette, rapidamente, di contare più volte la stessa quantità: essa, sappiamo, è un'addizione ripetuta con addendi tutti uguali.
Ricordando i tre modi diversi di scrivere la moltiplicazione,
a * b = c
c : a = b
c : b = a
riconosciamo nei nostri due problemi la prima situazione: il totale è sconosciuto (è un totale costituito da parti uguali).
Quindi, risolvo …….
Lascio a voi!
Altri esempi:
- Ho 35 matite colorate. Devo distribuirle in parti uguali fra 7 alunni. Quante matite riceve ogni alunno?
- Ho 27 matite colorate. Le distribuisco in parti uguali fra un gruppo di alunni. Ognuno di essi ne riceve 9. Quanti sono gli alunni?
Richiedono qualche riflessione in più.
Qualcuno di voi sarà portato a dire immediatamente, per il primo: riceve 5 matite perché 7*5 fa 35. E per il secondo, sono 3 gli alunni perché 9*3 fa 27.
In questo modo stiamo usando il metodo "diretto". Ma siamo favoriti dal calcolo semplice!
E nei casi più complessi? E se ho numeri decimali?
Allora riflettiamo: in questi problemi conosco il "totale"(rispettivamente 35 matite e 27 matite), da distribuire in parti uguali.
Posso quindi dire che è un totale costituito da parti uguali. Questo è importante sottolinearlo perché è da tale osservazione che intuisco sia stato ottenuto con una moltiplicazione! Non lo confondo perciò con totali ottenuti per somma.
Le parti uguali sono rispettivamente il numero di alunni (7 alunni) e il numero di matite (9 matite).
Se vi chiedo quale operazione mi permette di suddividere, distribuire in parti uguali, sono certa avete la risposta corretta!
E se vi chiedo qual è l'operazione inversa della moltiplicazione, ugualmente avete la risposta.
Rivediamo ancora una volta i tre modi diversi di scrivere la moltiplicazione,
a * b = c
c : a = b
c : b = a
Nei nostri problemi, quali termini sono conosciuti? Quale sconosciuto? Sapete fare la scelta giusta per la risoluzione?
Ritrovando i tre modi nel nostro primo problema, abbiamo:
[…] * 7 = 35
35 : 7 = […]
Nel secondo problema:
9 * […] = 27
27 : 9 = […]
In definitiva:
Prodotto : fattore conosciuto = fattore sconosciuto.
L'operazione di divisione mi permette di trovare il fattore sconosciuto!
Nota: Su questi due tipi di problemi possiamo aggiungere una ulteriore osservazione, che riguarda i due diversi modi di intendere la divisione:
a) 35 matite, divise in parti uguali fra 7 alunni: si tratta giusto di una distribuzione in parti uguali (7)
b) 27 matite, divise in parti uguali, ogni "parte" è costituita da 9 matite: si tratta di fare dei raggruppamenti (da 9 matite).
Troviamo (e risolviamo) altri esempi di problemi moltiplicativi di base, su questa pagina. Che ci ha dato diversi spunti....!
lunedì 1 ottobre 2007
Problemi additivi combinati
Trattando della risoluzione di problemi aritmetici [suggerisco la consultazione degli articoli precedenti, al tema dedicati, scegliendo la categoria : Risoluzione di problemi, sulla sidebar alla destra],
abbiamo finora esemplificato le tipologie e le "strategie" per comprendere e risolvere i problemi additivi semplici: quelli risolvibili solo con una operazione di addizione o sottrazione.
Dedico ancora un post ai problemi additivi, chiamiamoli "complessi".
Si tratta solo di una combinazione di problemi semplici e si risolvono con due o più addizioni o sottrazioni.
Come visto nei problemi semplici, ancor di più in questi, spesso è utile ricorrere a un disegno, allo schema che illustri la situazione.
1) Uno zainetto ha il costo di 30 €, un altro, trolley, costa 20 euro in più, un altro, ancora più accessoriato, costa 25 euro in più del secondo. Qual è il costo totale degli zainetti?
Lo schema suggerisce:

2° zaino: 30+20 = [...] euro
3°zaino: 30+20+25 = [...] euro
Costo totale: 30 + [...] + [...] = [...] € facile vero?
2) Un tratto di strada è lungo 20 Km. Un secondo tratto è lungo 5 Km in meno del primo, un terzo è lungo 10 in più del secondo tratto. Qual è la lunghezza complessiva dei tratti di strada?
1° tratto: 20 Km
2° tratto: 20 - 5 = [...] Km
3° tratto: (20-5) + 10 = [...] Km
Tot: [...] Km
Provate voi a schematizzare e risolvere?
In caso di difficoltà ogni lettore può segnalare lasciando un commento.
Così anche per ogni ulteriore dubbio o curiosità su problemi aritmetici particolari!
Il prox post riguarderà i problemi moltiplicativi.
giovedì 27 settembre 2007
Riprendiamo i problemi "più"!
Continuiamo la nostra carrellata sui problemi di tipo additivo, ancora con qualche esempio che richiede un po' di riflessione in più.
Nell'esempio seguente potremmo riconoscere delle "relazioni composte" fra grandezze, fra quantità.
- Marta ha 3 anni in più di Sandra. Sandra ne ha 5 in meno di Franca. Franca è più grande o più piccola di Marta? Di quanti anni esattamente?
Come detto altre volte, uno schema può essere di grande aiuto per comprendere e risolvere il problema.
Osservatelo con attenzione, poi risolvete voi. E' facile!
Come secondo esercizio vi propongo di inventare voi un problema con "relazioni composte" seguendo l'esempio.
Il più simpatico sarà pubblicato !!!
martedì 11 settembre 2007
Problemi più.
...più impegnativi. Ma mica tanto!
Procediamo con i nostri esempi di problemi solo con addizione e sottrazione (additivi), che possono tuttavia richiedere una riflessione maggiore.
Gli esempi riguardano ancora delle trasformazioni di quantità, di misure.
1) Maria ai suoi risparmi ha potuto aggiungere ieri pomeriggio 5 euro. Oggi ha fatto delle piccole spese. Riconta i suoi risparmi e verifica che ha 1 euro in meno rispetto a ieri mattina. Quanto ha speso Maria?
Dobbiamo leggere con attenzione. Non sappiamo a quanto ammontassero i risparmi di Maria, ma:
Il testo ci dice che 5 euro sono stati aggiunti ai risparmi, ieri pomeriggio.
Oggi, quindi dopo aver aggiunto i 5 euro, Maria ha fatto spese.
Verifica che possiede 1 euro in meno rispetto a ieri mattina, quindi rispetto a prima che aggiungesse i 5 euro.
Traduciamo in linguaggio matematico: indichiamo con "Euro risparmiati", gli euro aggiunti ai risparmi, con "Euro in meno", quelli che Maria si ritrova rispetto a prima del risparmio.
Euro risparmiati: 5
Euro in meno: 1
Euro spesi?
Mi sa che Maria deve stare attenta con le spese! :-)
Se ha 1 euro in meno, lo ha speso. E aveva anche aggiunto 5 euro. Quindi:
Maria ha speso i 5 euro risparmiati e .... un euro in più!
Completate:
i 5 euro e 1 euro costituiscono il [......] della spesa.
2) Luigi ha 4 macchinine da collezione in più rispetto a Luca. Luigi regala 6 macchinine. Chi possiede più macchinine ora: Luigi o Luca? Esattamente quante macchinine ha in più?
A volte è comodo per comprendere meglio un problema, ricorrere a uno schema, a un disegno che mostra la situazione:
Dovete inserire, opportunamente, nelle parentesi quadre i termini: i nomi propri, Luigi e Luca; 2; più.
Oppure: i nomi propri, Luigi e Luca; 2; meno.
3) Marco ha 8 figurine in più di Sandro. Sandro regala delle figurine e ne ha ora 11 meno di Marco, mentre il numero di figurine di Marco è lo stesso. Quante figurine ha regalato Sandro?
Provate da soli ricorrendo allo schema! Ispiratevi a quello del precedente problema.
venerdì 7 settembre 2007
Risoluzione di problemi aritmetici_3
Continuiamo con i nostri problemi additivi di base.
Come già detto, è bene riconoscere la caratteristica del problema, o "inquadrarlo".
Negli esempi che seguono riconosciamo una relazione fra misure, un confronto fra quantità.
1) Gianni ha 8 anni, la sorella ha 3 anni in più. Quanti anni ha la sorella di Gianni?
a + b = c
Qual è il termine sconosciuto? Non avete bisogno di aiuto, sù....
2) Luca è alto 145 cm, Marco 139 cm. Quanti cm in più è alto Luca rispetto a Marco?
Tra Luca e Marco c'è una differenza di altezze. Vi dice nulla? Conosciamo questa differenza?
Come si trova una differenza? Conoscere i termini delle operazioni è importante!
Vi ricordo: minuendo, sottraendo, differenza. Penso di avervi aiutato tanto!
3) Giulia ha 8 euro meno di Luisa, che ha 17 euro. Quanti euro ha Giulia?
Anche qui c'è una differenza fra i gruzzoletti di Giulia e Luisa. Si presenta in maniera diversa vero?
Sì, questa volta la differenza è conosciuta, sono gli 8 euro in meno che possiede Giulia rispetto a Luisa.
ma:
a + b = c
c - b = a
c - a = b
Capite perché i modi di scrivere l'addizione sono tre e non solo due?
Il secondo e il terzo modo possiamo interpretarli così:
Totale - parte = differenza
Totale - differenza = parte
Risolto il problema della differenza di euro! :-)