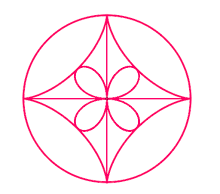Ragazzi,
la matematica è ...
Voi che idea avete? Cos’è per voi la mate?
Beh, intanto con la matematica si può dire ...quasi tutto! E se non proprio tutto, si possono esprimere molte idee: essere tra, essere parte e altro, essere il più grande, il più piccolo, appartenere, generare, sovrapporre, convergere, ecc.
La matematica è un linguaggio!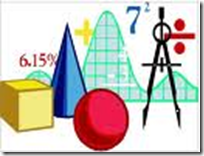
Se si dice espressioni matematiche è perché la scrittura esprime qualcosa, un’idea, un fatto.
E non è un linguaggio segreto perché le sue regole di scrittura sono pubbliche, chiunque le può conoscere. Anzi, tutti i ragazzi come voi non solo possono, ma DEVONO conoscerle o arrivare a conoscerle!
Tante parole della matematica provengono dalla lingua corrente: articoli, avverbi: dentro; congiunzioni, verbi: costruite, trovate, determinate, tracciate, ecc.
Poi ci sono parole specifiche della matematica, spesso nomi di oggetti, mediana, asse, diagonale, cilindro, ... ma anche aggettivi: isoscele, parallelo, pari, ...
Per finire troviamo i simboli specifici del linguaggio matematico che permettono di scrivere in modo semplificato operazioni: +, x, ... , relazioni: =, //, ...
Denis Guedj, un matematico, scrittore di bei romanzi matematici, recentemente scomparso, in un suo libro La matematica spiegata alle mie figlie, chiacchiera così con la figlia (che domanda, domanda...):
Perché si passa il tempo a scrivere uguale, =?
Riesci a immaginare una matematica senza il segno di uguaglianza? E’ il segno più importante della matematica. Quando scrivo: 2 = 1 + 1 cosa sto dicendo?
Che il numero 2 e il numero (1 + 1) sono LO STESSO NUMERO, che sono due modi diversi di vedere lo stesso numero, ecco perché li uguaglio. Ancora di più: posso uguagliare tutte le espressioni possibili di 2:
(1 + 1) = (5 – 3) = (10/5) = (2 x 1) = ...
E cosa ti importa?
A seconda di cosa mi serve posso usare una delle sue innumerevoli espressioni. Posso avere dei motivi per rappresentare 2 come somma o come differenza e così via.
Il contrario di uguale è differente, diverso, non lo stesso, che si scrive come un uguale barrato " ≠ "
Soprattutto non bisogna confondere differente con maggiore o minore, " › ", " ‹ "
L’uguale è sempre esistito?
Il concetto di uguaglianza sì, il segno no. Nel 1557 un medico inglese, Robert Recorde, ha avuto l’idea di tracciare il segno =. Quando gli hanno chiesto la ragione di questa scelta ha risposto: “Ho scelto una coppia di parallele o di linee gemelle, perché nulla si assomiglia di più di due gemelli”
E i simboli + e – ?
E’ una storia di casse
Di casse?
Intorno al 1500, in Germania, alcune merci venivano vendute dentro casse di legno. Quando erano piene dovevano pesare 4 centner (più o meno 50 chili). Se una pesava un po’ meno, per es. 5 libbre (1 libbra=453,6 grammi) meno di 4 centner, si scriveva sulla cassa: "4c – 5l".
Se pesava di più, per esempio 5 libbre in più di 4 centner, si barrava il tratto orizzontale per negare quanto scritto nel caso precedente, e si scriveva sulla cassa: "4c + 5l".
Gli egiziani invece usavano i geroglifici:
addizione
sottrazione
Su questi disegni si può vedere:
addizionare: le due gambe marciano nel senso della scrittura
sottrarre: marciano in senso inverso
Quindi il più è un meno barrato e differente è un uguale barrato.
Giusto!
E voi, ragazzi: altre domande?
...........................