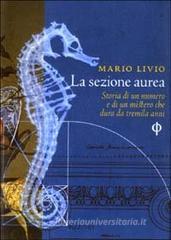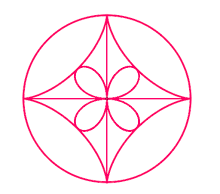Bel titolo no?
Avevo chiuso questo post, così: "Una volta scoperti, i numeri di Fibonacci sembrano saltar fuori dappertutto, non solo nella matematica astratta ma in quella applicata e nella natura in genere. "
Dunque eccovi ancora un bel passo da "La sezione aurea" di Mario Livio, che porta giusto il titolo che ho voluto dare a questo post.
La successione delle foglie e dei rami ha invece una componente rotatoria, che con l'avanzamento verso l'alto traccia intorno al fusto un'elica immaginaria:
Schemi analoghi di unità ripetitive sono formati anche dalle squame delle pigne e dai semi del girasole.
Il fenomeno ha il nome scientifico di fillotassi (dal greco, «disposizione delle foglie»), un sostantivo coniato nel 1754 dal naturalista svizzero Charles Bonnet (1720-1793).
Per esempio, nei boschi di tigli le foglie si collocano in genere da due parti opposte (corrispondenti a un mezzo giro intorno al fusto), uno schema descritto come «quoziente di fillotassi 1/2».
In altre piante, come il nocciolo, il rovo e il faggio, il passaggio da una foglia all'altra comporta un terzo di giro («quoziente di fillotassi 1/3»).
La figura1 illustra un caso in cui occorrono tre giri completi per passare attraverso otto rami (corrispondente a un «quoziente di fillotassi 3/8»).
Avrete forse notato che le frazioni citate sono rapporti di termini alternati della successione di Fibonacci.
Il fatto che le foglie delle piante seguano certi schemi era già stato notato nell'antichità (Teofrasto -c. 372-287 a.C., Plinio il Vecchio -23-79 d.C.)
Lo studio della fillotassi non andò molto oltre queste prime osservazioni qualitative fino al XV secolo, quando Leonardo da Vinci (1452-1519) aggiunse un elemento quantitativo, osservando che alcune foglie erano disposte secondo uno schema a spirale, a cicli di cinque (cioè secondo angoli corrispondenti a 2/5 di un angolo giro).
Il primo a scoprire (intuitivamente) il rapporto tra fillotassi e numeri di Fibonacci fu Keplero, che scrisse: «È in modo paragonabile a questa serie che si sviluppa da sé [un'allusione alla natura ricorsiva della successione di Fibonacci] che, a mio avviso, funziona la naturale facoltà di accrescimento. Per questo il fiore innalza il vero e proprio vessillo di questa facoltà, cioè il pentagono».
Charles Bonnet diede inizio al vero e proprio studio della fillotassi descrittiva. Nel suo libro del 1754, Recherches sur l'Usage des Feuilles dans les Plantes (Ricerche sul l'uso delle foglie nelle piante), egli dà una chiara descrizione della fillotassi con quoziente 2/5..
La storia della vera fillotassi matematíca inizia però nel XIX secolo con gli studi del botanico Karl Friedrich Schimper (del 1830), di Alexander Braun (del 1835) e del cristallografo Auguste Bravais, insieme al fratello Louis, un botanico (del 1837).
Questi studiosi scoprirono la regola generale secondo cui i quozienti di fillotassi si possono esprimere come quozienti dei numeri di Fibonacci (come nei casi già menzionati delle fillotassi 2/5 e 3/8) e notarono anche la comparsa di numeri di Fibonacci consecutivi nelle disposizioni a spirale delle squame dell'ananas e delle pigne d'abete.
L'ananas, in particolare, è un magnifico esempio di fillotassi basata sui numeri di Fibonacci.
Ognuna delle squame esagonali che rivestono questo frutto appartiene a tre diverse spirali.
Nella figura2 è evidenziata una delle 8 file parallele che salgono con gradualità da sinistra a destra, una delle 13 che salgono più rapidamente da destra a sinistra, e una delle 21 file che salgono quasi verticali da sinistra a destra. La maggior parte degli ananas presentano sulla superficie 5, 8, 13 o 21 spirali via via più ripide di squame. E tutti i numeri di spirali sono numeri di Fibonacci.
Come accade che le piante dispongono le foglie e altre loro parti secondo schemi basati su tali numeri?
La crescita delle piante ha luogo in corrispondenza dell'apice del fusto, dove si trova un tessuto giovane atto all'accrescimento chiamato «meristèma» .
Un apice vegetativo ha una forma pressappoco conica, restringendosi verso la sommità. La figura3
mostra un fusto dall'alto, con le foglie numerate secondo l'ordine di formazione. L'abbozzo della foglia «0», che si è formato per primo, è il più basso rispetto all'apice vegetativo e il più lontano dal centro del fusto.
Il botanico A. H. Church sottolineò per la prima volta l'importanza di questa rappresentazione per la comprensione della fillotassi. Quello che scopriamo (immaginando una linea curva che colleghi le foglie 0-5 della figura3) è che le foglie si succedono lungo una stretta spirale, chiamata «spirale vegetativa».
L'importante dato quantitativo che caratterizza la disposizione delle foglie è l'angolo formato dalle linee rette che collegano il centro del fusto agli abbozzi delle foglie (per esempio, gli abbozzi 0 e 1 della figura3).
Una delle scoperte dei fratelli Bravais nel 1837 fu che nuove foglie avanzano lungo la circonferenza formando un angolo pressappoco costante, e che quest'angolo (noto come angolo di divergenza) è di solito prossimo a 137,5°.
Vi turba apprendere che questo valore è determinato dal rapporto aureo?
L'angolo maggiore risultante dalla divisione dell'angolo giro secondo il rapporto aureo misura 360°/φ, ovvero 222,5°.
Ciò significa che l'angolo minore in cui l'angolo giro è diviso misura 360°-222,5°, cioè 137,5° (ed è a volte chiamato «angolo aureo»).
Il matematico G. van Iterson ha dimostrato che, collocando una fitta serie di punti separati da 137,5° lungo una spirale avvitata strettamente, l'occhio riceve l'impressione di due famiglie di spirali, che si avvitano l'una in senso orario e l'altra in senso antiorario.
I numeri di spirali delle due famiglie tendono a essere numeri consecutivi di Fibonacci, e infatti i rapporti tra questi numeri si avvicinano al rapporto aureo.
Simili spirali orarie e antiorarie trovano una delle realizzazioni più spettacolari nell'infiorescenza del girasole.
Ammirando un girasole
è facile notare, al centro dell'infiorescenza, l'insieme di spirali orarie e antiorarie che si intersecano con regolarità.
È chiaro che gli elementi dell'infiorescenza crescono in modo da occupare nel modo più efficiente lo spazio circolare al centro del fiore. Il numero di spirali dipende di solito dalle dimensioni del girasole.
Nel caso più comune ci sono 34 spirali avvolte in senso orario o antiorario, e 55 avvolte nel senso opposto, ma sono stati osservati girasoli con rapporti del numero di spirali di 89/55, 144/89 e perfino di 233/144.
Ancora una volta tutti i numeri citati sono termini (contigui, in questo caso) della successione di Fibonacci.
La quantità e la disposizione dei petali di alcuni fiori sono anch'esse collegate coi numeri di Fibonacci e il rapporto aureo.
Quanti di noi, almeno una volta nella vita, hanno «interrogato» i petali della margherita intorno alla fatale questione (m'ama o non m'ama)?
La maggior parte delle margherite di campo hanno 13, 21 o 34 petali - numeri ormai familiari. (Si noti che i primi due sono dispari; perciò, cominciando con «m'ama» il buon esito è garantito.) Il numero di petali riflette semplicemente il numero di spirali in ogni famiglia.
Anche la mirabile corolla della rosa è collegata al rapporto aureo.
Il millenario enigma dell'origine della fillotassi si riduce a un solo interrogativo fondamentale: perché la successione circolare delle foglie si basa sull'angolo aureo di 137,5°?
I tentativi di rispondere a questa domanda sono riconducibili a due «scuole»: quella che si concentra sulle proprietà geometriche delle disposizioni, e quella che considera i fenomeni geometrici come altrettante manifestazioni di cause sottostanti di natura non geometrica.
Per quanto riguarda la prima scuola, ricerche fondamentali (effettuate, tra gli altri, dai matematici Harold S. M. Coxeter e L Adler e dal cristallografo N. Rivier) hanno rivelato che germogli posti lungo la spirale generatrice risultano più fitti e usano lo spazio con più efficienza se separati da angoli aurei. In parte, il motivo è facile da capire.
Se l'angolo di divergenza avesse, poniamo, un'ampiezza di 120° (360°/3), o di qualunque altro prodotto razionale di 360°, le foglie si allineerebbero in modo radiale (lungo tre linee, nel caso dell'angolo di 120°) lasciando inutilizzata una grande quantità di spazio tra una linea e l'altra. D'altra parte un angolo di divergenza come quello aureo (multiplo irrazionale di 360°) assicura che i germogli non si allineino, riducendo al minimo lo spreco di spazio.
L'angolo aureo è in questo preferibile ad altri multipli irrazionali di 360° perché il rapporto aureo è «il più irrazionale» dei numeri irrazionali, in questo senso: sappiamo che φ può essere espresso come una frazione continua che non contiene altri numeri oltre a 1; e una frazione continua di questo tipo converge più lentamente di qualsiasi altra.
Il rapporto aureo è quindi più lontano di qualunque altro irrazionale dal poter essere espresso come frazione.
Spero che la prossima volta che gusterete una fetta di ananas, manderete delle rose a una persona cara o ammirerete i Girasoli di Van Gogh, il piacere che ne trarrete sarà arricchito dalla consapevolezza che dietro ai loro pregi estetici si celano le misteriose proprietà numeriche di φ.
Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la crescita delle piante è legata anche a fattori diversi dall'uso ottimale dello spazio. Perciò, le regole di fillotassi appena descritte non valgono in ogni caso e circostanza, come le tipiche leggi fisiche. Si tratta piuttosto, per usare le parole del matematico canadese Harold Coxeter, di «affascinanti e prevalenti tendenze».
La botanica non è il solo ambito naturale in cui il rapporto aureo e i numeri di Fibonacci appaiono come in filigrana. La loro presenza si può riscontrare su scale di grandezza che vanno dal mondo microscopico alle galassie. E non di rado tale presenza assume la forma visibile di spirali particolarmente armoniose.