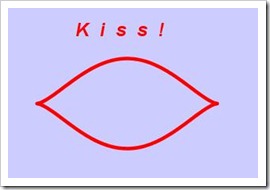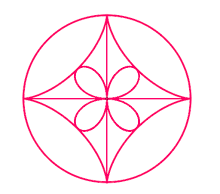Fra i matematici del XVII° sec. la concoide di Nicomede ebbe grande popolarità:
Fermat e
Roberval completarono la ricerca sulle tangenti alla curva.
Huygens giunse alla costruzione dei flessi applicando il metodo di Cartesio e trovò che l'area tra i rami della curva è infinita.
Newton propose di includerla, insieme alla retta e alla circonferenza, tra le curve "di buon servizio" per i problemi di terzo e quarto grado.
L'
equazione della curva in coordinate polari è:
$ρ\,=\, \frac{ a }{ cos(θ)} + c$
l'equazione cartesiana:
$y\, =\,\pm \frac{ x }{ x -a} \sqrt{ c² - (x - a)² }$
Come si costruisce la concoide di Nicomede.Sia data una retta
a, un punto
A non sulla retta. Si traccia la retta
b perpendicolare ad
a e passante per
A, con
D punto di intersezione con
a e con
DC di lunghezza fissata
c. Si ruota la retta
b attorno ad
A. Si traccia quindi la circonferenza di centro un punto
C1 della retta
a e raggio
c. Si individuano i punti di intersezione,
F e
G, della circonferenza con la retta
b' (
b ruotata di un angolo α).
La concoide è il luogo dei punti
F e
G.
Clic per visualizzare l'animazione su geogebra, che evidenzia i parametri variabili ...
In particolare si nota che la forma della concoide è sempre simmetrica rispetto alla retta
b: questa passa per il
polo A e per i vertici della concoide. La retta base
a è un
asintoto sia per il ramo esterno che per il ramo interno ma la forma del ramo interno della concoide dipende dal rapporto fra i due parametri
a e
c ossia tra le lunghezze dei segmenti AD e il raggio della circonferenza:
per
a ‹ c il ramo interno ha un cappio e il polo è un nodo,
per
a = c si una cuspide, il cappio del ramo interno si riduce al polo,
per a › c il ramo interno non passa per il polo e quest'ultimo è un punto isolato della curva.
Per l'animazione "
conchiglia" clic
QUILa curva base, anziché una retta, può essere qualsiasi curva.
Se per es. la curva è una circonferenza, e il punto fisso A è un punto della circonferenza, la concoide è una
lumaca. Se la lunghezza fissa
c è uguale al raggio della circonferenza, la concoide diventa una
cardioideSe la curva base è una spirale di Archimede e il punto fisso è il centro della spirale, la concoide è ancora una
spirale di Archimede.
(torneremo su lumaca e spirale?)E ora la seconda curva...La conchiglia di DürerImparentata con la concoide di Nicomede, la
conchiglia di Dürer è una curva studiata dal grande artista, pittore e incisore, e matematico
Albrecht Dürer.
Nella sua opera
Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt descrive un apparecchio per tracciare una curva da lui chiamata
Muschellinie (in tedesco, "curva a conchiglia").
La curva ha un ramo di concoide e un altro con andamento sinuoso. Graziosissima nella sua semplicità!
Clic per aprire l'animazione con geogebra.